«Si può fare»: la lingua in quanto gadget elettorale
[questo articolo è stato scritto per il sito dell'Istituto Linguistico Campano]
Durante la campagna elettorale che si è conclusa lunedì scorso, con i risultati ormai ben noti, il Partito Democratico aveva scelto come slogan l’adattamento, rabberciato in italiano, rabberciato in italiano, dello «Yes, we can» del rapper Will I Am e fatto proprio da Barack Obama, il front runner «democratico» alla presidenza degli Stati Uniti d’America: «Si può fare». Ora abbiamo appreso che no, non si è potuto fare, nonostante la formula nostrana fosse alquanto più modesta e molto meno assertiva di quella scelta da Obama. Sapeva già un po’ di sconfitta, se ci si pensa… Nel dramma delle possibilità sciupate, delle cose che si sarebbero potute fare e la maggior parte dei votanti ha scelto d’impedire alla radice, vi è forse, a mio parere, più della lotta del possibilismo contro i numeri schiaccianti delle probabilità, il pressappochismo con il quale ci si è avvicinati alla realtà del paese e ai suoi bisogni.
Esemplare è a tal proposito, mi sembra, il modo di relazionarsi con le differenti identità linguistiche presenti internamente alla nazione. Un osservatore francese non può che rimanere colpito dal fatto che il « Si può fare » sia stato tradotto in parecchie lingue regionali italiane. Magliette, locandine e manifesti di sostegno alla campagna esibivano la stampa d’una parte del multilinguismo italiano, così ricco e peculiare. Sul sito del PD, si poteva anche trovare, in mezzo agli altri materiali di propaganda, una mappa d’Italia tricolore, ritagliata in vari pezzi come un puzzle e che, prima della sua probabile scomparsa, provvedo a trasferire qui sotto.
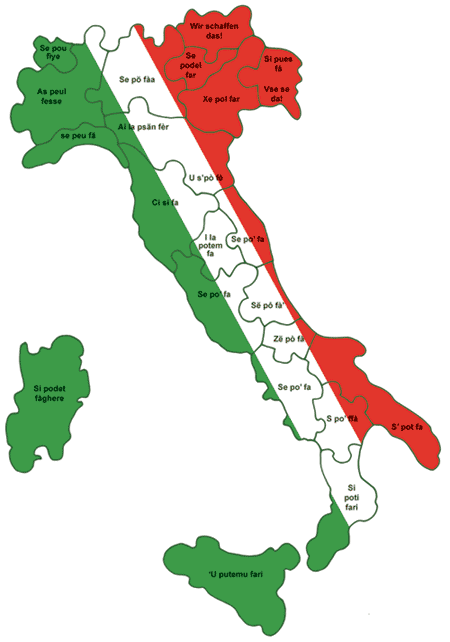
Mappa elettorale pubblicata sul sito del Partito Democratico
Ogni tassello corrisponde a una regione, dove si può ascoltare una o due maniere di dire «Si può fare»: dal «Ci si fa» dei toscani fino al «Wir schaffen das» del Südtirol; dal «Se peu fä» ligure al «’U putemu fari» dei siciliani. Così Veltroni, quando ha fatto il suo giro d’Italia in quarantacinque tappe, incontrava ogni giorno o quasi simpatizzanti del nuovo suo partito che esibivano in vari modi lo stesso slogan, ma nel «dialetto» proprio. A Rimini, per esempio, ha voluto mettersi in mostra con dei giovani che indossavano magliette con la scritta «us po’ fe».
È una cosa esotica per un francese, perché nel mio paese nessun partito, ahimè, nemmeno quelli che sostengono ufficialmente le lingue regionali (bisognerebbe poi limitarsi al singolare, perché al di fuori dei Verts non ve ne sono altri), oserebbe fare una cosa simile. Da noi una tale iniziativa significherebbe stroncare l’unità nazionale e andare incontro all’accusa di separatismo… Le condanne verrebbero da ogni luogo e da tutti gli orientamenti politici, dall’estrema destra fino all’estrema sinistra.
Invece ciò non ha destato in Italia quasi nessuna critica di fondo e la sola obiezione che io conosca è quella apparsa in un blog di destra con l’accusa di far passare tutti gli italiani come «provinciali». Credo che questo sia dovuto al fatto che i numerosi linguaggi regionali, neutralizzati come «dialetti» (l’unico termine usato purtroppo nel corso di questa campagna e in netta contraddizione con le leggi regionali che usano quello di «lingue»), non rappresentano, in quanto tali, alcun esito politico (e ciò per qualunque partito, compresa la Lega Nord), e nemmeno una valenza culturale, come si può verificare leggendo la scarsa letteratura dedicata a questa iniziativa.
Del resto le ragioni date dallo stesso PD per giustificare una simile campagna sono contenute pressoché nelle sole parole ribadite ovunque, quasi sempre senz’alcun commento, dal diretto responsabile della comunicazione Ermete Realacci: «Vogliamo trasmettere il messaggio di un’Italia che parli con una sola voce, ma che pensi con le diverse menti dei suoi territori». L’espressione è d’altronde strana, perché l’iniziativa mirava a fare esprimere la stessa cosa a tante voci diverse, e dunque a unirle in una sola mente per finalità da molti condivise.
Quale potrebbe essere pertanto qui il senso dell’espressione «diverse menti dei suoi territori»? Forse diverse peculiarità culturali? Non lo si ribadisce con chiarezza e, inoltre, parlare di «voce» e di «menti» dispensa dal pronunciarsi sulle «culture» e sulle «lingue». Lo stesso uso generico del termine «dialetti», in questo sistema binario (dialetti/lingua), esclude di per sé qualsiasi accenno all’esistenza sulla penisola di lingue vere e proprie al di fuori dell’italiano. Senza nessun intento polemico, si può costatare che la propaganda del PD è del tutto regressiva in confronto allo statuto giuridico di buona parte degli idiomi sollecitati e al principio costituzionale della pari dignità sociale delle lingue.
Come dice un altro testo pescato in rete, la mira, sollecitando le parlate locali, era di «arrivare proprio al cuore di tutti»; lo scopo, del tutto comunicazionale e propagandistico, era di produrre l’illusione che nessuno era stato dimenticato, che anche l’angolo più recondito d’Italia è stato preso in considerazione, tuttavia per mezzo di una specificità che non andava aldilà di un’espressione pittoresca. Tanti italiani potevano giustamente sentirsi umiliati e offesi da quest’assegnazione superficiale e decorativa. Molto rilevante mi sembra a tal proposito il fatto che nella rappresentazione geografica gli slogan sono immersi nei colori della bandiera italiana che ricopre interamente la penisola e senza nessuna indicazione sulle unità linguistiche e le identità regionali.
La mappa a noi proposta è d’altronde del tutto fittizia e siamo molto lontani da una rappresentazione di tutte le comunità linguistiche. È del tutto fittizia perché suggerisce l’esistenza d’uno solo o due al massimo «dialetti» in ogni regione amministrativa, arrestandosi di netto ai suoi confini, e l’idea stessa del puzzle, se induce forse l’idea di una qualche arbitrarietà dei limiti, non invita poi a pensarne la porosità. Le regioni, ovviamente, non sono gabbie linguistiche ed esistono mappe delle zone linguistiche abbastanza accurate, che danno una rappresentazione ben diversa della complessa realtà linguistica italiana.
Per esempio è strano l’avere evidenziato per la Sardegna una sola versione dello slogan, visto che vi coesistono almeno quattro grandi zone linguistiche e un isolato catalano. La stessa cosa vale poi per la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia... Le minoranze linguistiche arbëresh, grika, croata ecc. sono state del tutto dimenticate... Non vedo nemmeno traccia della lingua d’oc parlata in una parte delle vallate alpine (per non dire di quella di Guardia Piemontese)… Se gli ideatori della carta avessero voluto prenderle in conto, avrebbero dovuto addentrarsi nella densa realtà linguistica e culturale del paese. Mi pare chiaro che questo non sia stato il progetto, e nemmeno l’interesse, dei comunicatori di Veltroni, né posso credere poi che si siano avvalsi dei consigli di qualsiasi linguista nell’ideazione geografica, perché nessun «dialettologo» italiano avrebbe potuto farsi garante o addirittura autore di tale semplificazione e soprattutto di una falsificazione così palese.
Si resta stupefatti, a voler fare un altro esempio, quando si legge in qual modo è stata fatta la scelta della traduzione dello slogan in Molise. È quello che viene esposto dall’agenzia giornalistica Aise, data come «leader per gli italiani nel mondo», secondo il sito molisano Nuvole in rete. Il «dialetto» molisano sarebbe, secondo quanto afferma questa fonte, «uno dei più complessi e soprattutto sconosciuti». Lo staff della comunicazione del PD si è rivolto allora all’associazione Forche Caudine, «circolo storico di molisani a Roma» (questo sembra significare dunque che i molisani del Molise sono meno affidabili di quelli della capitale), che ha scelto di «concertare» la decisione con il ricorso «alle nuove tecnologie» per sollecitare via e-mail i pareri di quasi tremila molisani sparsi in tutto il mondo.
Il criterio di selezione stabilito è stato semplicemente quello della «maggioranza» e così «Zë pò fà», scritto con la «ë muta» (sic!), lo si è giudicato degno di scriversi sulle magliette e la mappa-puzzle d’Italia. La consultazione, però, secondo la stessa fonte, «ha avuto il merito di far emergere le più disparate istanze», tra l’altro con la versione dello slogan in croato, albanese e serbo, minoranze linguistiche presenti in Molise... Inoltre si riferivano numerose varianti territoriali, quali «Cë pò fà» o «Se po feaje». Il fatto che siano state scartate è motivato come una cosa giusta, profondamente democratica, visto che... non hanno avuto la maggioranza in un campione dei molisani fuori dal Molise.
Spetta dunque alla maggioranza degli internauti attivi (la questione della loro rappresentatività non viene certamente posta e sembra evidente che non può che essere superiore a quella degli idioti – intesi ovviamente in senso etimologico – i quali magari parlano giornalmente la loro lingua, ma non usano la rete per comunicare) di decidere qual sia l’espressione molisana più «autentica» e rappresentativa! Non si può immaginare concezione più aberrante non solo della democrazia – le minoranze sono ridotte al silenzio perché appunto non-maggioritarie –, ma anche della linguistica, visto che gli atti di linguaggio vengono trattati come opinioni. Cosa si direbbe se, per accertare le verità della fisica o della medicina, i ricercatori si basassero sui sondaggi d’opinione? In ogni caso quest’esempio mostra la completa mancanza di serietà di tutta la faccenda, in cui la lingua non è nient’altro che un gingillo elettorale.
Si consideri poi il caso, invero singolare, occorso allo slogan nella traduzione sua napoletana. Qui lo staff di Veltroni aveva maggior fiuto scegliendo, per averne lumi, di telefonare ad Amedeo Messina. Il presidente dell’Istituto Linguistico Campano ben chiariva ch’egli avrebbe rilasciato l’espressione partenopea del “si può fare”, ma non era questa uguale agli altri linguaggi della regione. Tuttavia la corretta trascrizione in napoletano da lui fornita era poi modificata in forma errata, così da costringere Serse Turao a una nota pubblicata qui sul sito con il titolo Veltroni e noi (clicca: ’o puosto e mparulianno) e a stampa su Il Mattino e Il Corriere del Mezzogiorno.
Lo stesura abborracciata della mappa degli slogan dialettali non ha certamente ottenuto un gran consenso. Strafalcioni sono segnalati di qua e di là. Si confronti anche il caso di Trieste, dove il motto è diventato «Xe pol far». Scrive Corrado Premuda sul sito Bora.la che si tratta di tre parole appena e una papera eclatante. Qui «la versione corretta sarebbe “Se pol far”: il “si” impersonale dell’italiano diventa “se” in triestino, non “xe”, terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo essere». Nella discussione degli internauti su questa messa a punto viene detto che si tratterebbe della versione veneziana, ed è quello che fa pensare anche la lettura stessa della mappa. In questo caso il triestino sparisce del tutto…
Un’altra cosa molto interessante è l’incontro di Veltroni, nel suo giro d’Italia, con i modi d’espressione «dialettali» quando diventano tramite del confronto sociale. Sulle peripezie del candidato alla presidenza del Consiglio si può leggere sul sito A sangue freddo il racconto di un incidente edificante sopraggiunto nel comizio a Padova. Un anziano gli ha chiesto «in puro e schietto dialetto patavino» come si possa vivere con meno di 500 euro al mese e aggiungeva altre parole imbarazzanti, secondo quello che ha sentito il testimone. L’uomo è stato preso dai carabinieri, ingiunto di mostrare i documenti e portato fuori della piazza. Ecco il tipo di manifestazioni dialettali che il PD preferirebbe senz’altro risparmiarsi…
Un’ultima cosa va notata: non solo la lingua nazionale e i cosiddetti «dialetti», ma molte altre lingue sono presenti sulla penisola italiana. Lingue per lo più parlate da cittadini extracomunitari vengono del tutto trascurate, anzi volutamente omesse nell’Italia dei molteplici linguaggi. Gli immigrati poi, di tante origini, qui parlano spesso i «dialetti» delle regioni in cui vivono, e anche per questo dovrebbero ricevere qualche maggiore attenzione da un partito di centrosinistra che ostenta la parola democrazia. Però il PD non presentava alcun immigrato nelle sue liste. Nemmeno uno… e questo è molto inquietante, perché, volendo o nolendo, si tratta di una modalità passiva di allinearsi sulla xenofobia sempre più clamorosa nel partito faidaté berlusconiano dopo aver integrato in sé l’estrema destra.
Lo ha puntualmente denunciato lo scrittore e antropologo algerino Amara Lakhous, che contesta una volta di più il rifiuto persistente di concedere il diritto al voto degli extracomunitari: «Gli italiani all’estero, che in Italia non vivono, possono votare. I figli di immigrati, che tifano per gli azzurri, parlano i dialetti locali e magari hanno sempre vissuto qui, non possono». Cosa, a tutti loro, abbia potuto mai significare di poter leggere o sentirsi dire in italiano, in piemontese o in napoletano che qualcosa si poteva fare, che era possibile farlo, io non so davvero... Ma so quello che provano a fare loro stessi, con le loro strategie di sopravvivenza quotidiana: cavarsela, farcela, riuscire, in tante lingue che la fittizia mappa della propaganda veltroniana non basta certo a contenere.
Jean-Pierre Cavaillé



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F28%2F115864%2F127634996_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F12%2F76%2F115864%2F126788466_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F99%2F115864%2F50180922_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F65%2F115864%2F81511110_o.jpg)