Sulla nozione di dialetto
|
e su questo blog in versione francese
|
|||||||
|
Nel suo pregevole intervento, pubblicato sul nostro sito il 30 aprile 2007, Nicola De Blasi crede innanzi tutto di dover chiarire come, definendo dialettale il napoletano, non si voglia fargli offesa, né in alcun modo disprezzarlo, ma che il termine sarebbe solo un sostantivo necessario alla chiarezza descrittiva nelle indagini scientifiche dei linguisti. In altre parole egli rivendica alle scienze la legittimità di scegliere di volta in volta termini e nozioni che utilmente definiscano l'oggetto verso cui converge la ricerca. Ora a me non pare che i giudizi espressi da Jean-Pierre Cavaillé sul saggio deblasiano " Per la storia contemporanea del dialetto nella città di Napoli ", comparso nel 2002 sulla specialistica rivista "Lingua e stile", muovano da un senso di disprezzo, oltraggio o vilipendio nei confronti del napoletano, perdipiù veicolato definendolo dialetto, in qualche modo percepito da De Blasi stesso dentro il testo del collega transalpino. Mi sembra conveniente precisare che una critica a proposito del termine dialetto investe l'uso che se ne fa come nozione che vuol essere scientifica, non certo questo o quel dialetto. Un'analisi corretta del problema ora in esame, proprio perché riguarda i campi della terminologia e della epistemologia, esula del tutto da ciò che l'illustre professore di linguistica italiana avverte come «un radicato pregiudizio anti-dialetto». La questione è tutta un'altra. Siamo veramente certi di chiamar le cose con il loro proprio nome? E su quali basi si legittima il potere di attribuire un nome agli strumenti in uso in ogni singola scienza? A nessuno viene in mente di gridare allo scandalo se sente dire pieve al posto di parrocchia, ma c'è bensì da protestare se qualcuno insiste nel confondere il sagrato con la chiesa, ovvero se si prende per dialetto ciò che ha tutte le carte in regola per essere una vera e propria lingua. Non sono certo io a dover ricordare l'aureo precetto d'uno dei padri nobili della linguistica, secondo il quale Ferdinand de Saussure ancora insegna che in tale scienza, diversamente da tante altre, una delle principali difficoltà consiste nel capire come non sia possibile parlare di un oggetto da diverse prospettive, perché, al contrario, «[...] è il punto di vista che fa la cosa» (Corso di linguistica generale , Roma-Bari, 1968, p. 26, col. 5). Oppure, come ha ribadito in seguito Luis Jorge Prieto, la linguistica non ha per proprio oggetto la realtà materiale, ma soltanto «[...] un modo di conoscere la realtà materiale» ( Pertinenza e pratica , Milano, Feltrinelli, 1976, p. 109). Quest'ultima, pertanto, sia essa dialetto o lingua, non ha mai una consistenza esterna, neutra e oggettiva, ma è il prodotto d'una scelta dello scienziato stesso o della comunità scientifica alla quale fa riferimento. Ora De Blasi ha ben ragione a ricordare che «la parola dialetto è correntemente usata negli studi linguistici scientifici», ed è proprio questa usanza che bisogna interrogare. In primo luogo per la sua "correntezza". L'usualità con cui detta nozione è adoperata non sarà forse troppo sbrigativamente lasciata correre con una concessione contrastante coi bisogni di chiarezza necessari alla linguistica e ai linguaggi collettivi? Egli stesso afferma che criterio della scelta del termine dialetto è la risposta all'esigenza di "chiarezza descrittiva" nella scienza che professa. Enunciato che sarebbe certamente giusto, se vi fosse per davvero piena corrispondenza tra nozioni, analisi e teorie che chiaramente descrivessero l'oggetto loro, come appunto il dialetto, definendo con la massima evidenza la gran parte dei fenomeni osservabili nel proprio campo di ricerca.
Ben è vero che l'uso consolidato tra i linguisti, in genere docenti universitari, di un loro lessico specialistico non è fortuito più di quanto lo sia la supina tolleranza di studenti e di cultori dilettanti. Non a caso questa egemonia della cultura cattedratica ricade nei linguaggi popolari, per i quali il termine dialetto ha il solo senso di ciò che non è "lingua italiana", senz'alcun riferimento né al prestigio, né alla nazionalità, ma solo a una funzione comunicativa. L'usanza condivisa di quel lessico è il prodotto di un'autoreferenzialità accademica, non in grado di comprendere il divario tra realtà del tutto esterna e autorità istituzionale e statuitaria conferita alla parola dei docenti, che di per sé tende ad escludere tanto il rapporto tra la produzione scientifica e gli oggetti della scienza quanto il rendimento informativo della comunicazione. Senz'alcun dubbio solo l'epistemologia può decidere sulle condizioni teoriche di una pratica scientifica che voglia definirsi rigorosa; tuttavia la linguistica delle pratiche linguistiche dimostra facilmente quanto debole e arbitrario sia l'impianto lessicale, e quindi di nozioni e di concetti, usati e imposti dagli esperti dei linguaggi. In politica, così come tra intellettuali, non vi è nulla di più concreto delle discussioni sulle parole. Modificare un significato o addirittura porre una parola al posto di un'altra quasi sempre vuole dire variare la visione della realtà che ci circonda e che noi stessi siamo. Tanto è vero che appunto questo si rivela uno dei criteri, forse il più immediato e ben diffuso, per qualificare come dialettale una qualsiasi parlata differente dalla propria e che si reputa "scorretta" non appena si discosti dalla varietà territoriale con cui si usa il medesimo modello prestigioso della lingua nazionale. Vorrà forse dire che col termine dialetto ogni linguista definisce un peculiare oggetto di ricerca, descrivendolo con la massima chiarezza. Ma nemmeno così stanno le cose. A lle origini dialetto designava un semplice colloquio, la conversazione schietta tra gli amici e i familiari, denotando in seguito il sermo unicuique genti peculiaris , nella definizione classica fornita da Robert Estienne (Robertus Stephanus) nel suo Thesaurus linguae latinae pubblicato nel 1532. In Italia solo dal 1724, ad opera del cruscante abate Anton Maria Salvini, è invalso l'uso d'intendere il dialetto col significato riduttivo di natia parlata, originaria di un particolare territorio. Scrisse infatti il Salvini: «I vostri natii dialetti vi costituiscono cittadini delle sole vostre città; il dialetto toscano appreso da voi, ricevuto, abbracciato, vi fa cittadini d'Italia» (Cit. in M. Cortelazzo, Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana , Pisa, Pacini, 1969, p. 13). Scelta dunque, come si può notare, imposta da una egemonia prima culturale e poi politica, che di scientifico ha ben poco, tranne il fatto di convenire ch'esso sia un sistema linguistico in grado di soddisfare solo alcuni aspetti dei bisogni espressivi, come il popolare e il quotidiano, ma non il tecnico, lo scientifico o il letterario e che, rispetto alla lingua ufficiale di uno stato, si distingue per lessico e fonemi propri, intonazione, morfologia e sintassi. Scelta, inoltre, che nel Settecento aveva un senso quale attualmente si ribalta in quello del volersi dichiarare cittadini dell'intero mondo, contrastando, al tempo stesso, egemonie globalizzanti che vorrebbero riunire e uniformare popoli e nazioni. A quest'ultimo progetto, com'è noto, si accompagna l'incubo del globish , un angloamericano planetario al quale va opponendosi il recupero diffuso dei linguaggi regionali a rischio di estinzione. Con tutto ciò quell'esigenza di chiarezza descrittiva conclamata da De Blasi a me non sembra soddisfatta. Non a caso, per dirla con parole di Claude Hagège, docente di linguistica al Collège de France, «la scelta dello statuto da attribuire a un idioma varia a seconda dei linguisti, e non tutti concordano sulla definizione apparentemente più semplice: una lingua è il dialetto che, fra quelli presenti in un dato momento, viene imposto da un'autorità politica in un determinato luogo, insieme al suo potere. [... Ma essa] non è necessariamente accettata da tutti i linguisti, [...] poiché variano le discriminanti utilizzate per stabilire se un certo idioma è un dialetto o una lingua» ( Morte e rinascita delle lingue , Milano, Feltrinelli, 2002, p. 135). Se questa definizione non bastasse a illuminarci, ma bisognerà pur dire che la tesi di Hagège ha molti predecessori e oggi sono ancor di più coloro che la condividono, si può sempre chiedere chiarezza ai più valenti lessicografi italiani, compulsando i loro dizionari alla ricerca di elementi in grado di far luce a quanti, me compreso, non sono affatto specialisti e tuttavia tengono fede con perseveranza a un uso democratico di tutte le scienze, oltre a nutrire una grandissima amicizia per le proprie lingue. Però mi sarà concesso di partire da un confronto con alcune posizioni "straniere", per poi giungere alle nostre vicissitudini italiane. Tenendo in primo luogo conto della nozione che del dialetto offrono i linguisti canadesi e statunitensi, con la quale essi designano ogni varietà geografica di una lingua. Per esempio è un dialetto, a loro avviso, lo spagnolo messicano o quello d'Argentina, il francese del Québec o l'angloamericano degli Stati Uniti, così come noi italiani potremmo dire un dialetto l'italiano romanesco o quello parlato a Napoli o in Sardegna. I medesimi linguisti, tralasciando il connotato geografico, chiamano social dialect i linguaggi popolari provenienti dalle lingue originarie, come il black-english degli Stati Uniti e il cockney del sud-est d'Inghilterra. Lo stesso italiano standard potrebbe essere pertanto uno dei dialetti dell'italiano. In Europa, invece, la maggioranza dei linguisti interpreta il dialetto come la nozione delle varietà prodotte in un processo diacronico, diatopico e diastratico da un'antica lingua ai suoi linguaggi odierni. In tal caso del latino son dialetti tutte le lingue romanze, ma il latino stesso, a propria volta è un dialetto del sottogruppo occidentale del gruppo italico della cosiddetta famiglia indo-europea.
Quello longobardo che calò da noi nel 568 è stato di sicuro d'importanza eccezionale (cf. S. d'A. Avalle, Protostoria delle lingue romanze, Torino, Giappichelli, 1965, p. 78), stabilendo apporti di linguaggio in grado di costituire nelle diaspore locali di un latino frammentato novità d'evoluzione ben diverse dai modelli originari. Gli autonomi sistemi linguistici italiani, quegli stessi che più di un linguista insiste a etichettare come dialetti, si contrappongono alla nozione di dialetto proprio perché non hanno affatto segni e regole combinatorie della stessa origine del sistema linguistico toscano divenuto lingua nazionale. Vale a dire che il piemontese e il napoletano, il veneto e il pugliese, il romagnolo e il siciliano, a voler fare alcuni esempi, non sono nati dall'evoluzione del fiorentino o, a maggior ragione, dalla contaminazione dell'italiano. Inoltre essi sono delle lingue regionali, o minoritarie se così vi piace, per il semplice motivo che a loro volta si differenziano al proprio interno. Non c'è chi non senta o legga, infatti, quanta differenza intercorra tra la lingua piemontese e il dialetto d'Asti, tra la lingua napoletana e il dialetto di Pozzuoli, tra la lingua veneta e il dialetto veronese, e così via, per non parlare, infine, della grande varietà frapposta tra il palermitano e il catanese. Tali sottoinsiemi d'una lingua regionale potrebbero da noi dirsi dialetti, ma soltanto con il senso dato a tale termine in ambito anglosassone, e cioè di varietà linguistica, senz'alcuna connotazione d'altro tipo. Anche gli spagnoli adoperano il termine dialecto , aggiungendo al senso della varietà quello della stretta derivazione, respingendo dunque connotati egemonici o spaziali. Molti sono poi i linguisti che applicano il criterio della non standardizzazione, con lo scopo di creare una linea di confine tra dialetti e lingue, ovverosia credendo che l'assenza di una normativa connoterebbe una realtà linguistica come dialettale. Un buon punto di partenza per l'esame della nozione di dialetto nella linguistica italiana è forse quello della voce scritta da Giulio Bertoni che tuttora si può leggere nella ristampa più recente del XII volume della Enciclopedia italiana (Roma, Ist. Encicl. Italiana, 1931, p. 734). «La concezione dei dialetti come altrettanti tipi linguistici circoscritti entro certi limiti è giustificata da bisogni e da necessità scientifiche; e non si può dire che sia una concezione falsa, perché, rigorosamente parlando, non potrebbe neppure essere utile, se non contenesse elementi di verità. Ma questi elementi stanno in ognuno dei fenomeni considerati, non già nella nozione generale, che vuole tutti stringerli in fascio». In altri termini, a parere del filologo di Modena, ciò che i linguisti intendono con la nozione di dialetto serve solo a dettagliare la parlata tipica di una comunità determinata in uno spazio circoscritto, ma giammai una lingua, soprattutto quella giunta a produzione letteraria. A voler stringere in un fascio solo i singoli dialetti di una lingua la nozione generale di dialetto, ovvero ciò che in seguito dirò come l'essenza sostanziale dell'oggetto nominato, sussumendovi perfino alcune lingue i cui parlanti assommano a milioni di persone, rende la sua medesima nozione inservibile ai linguisti e incomprensibile ai profani. Nel Grande dizionario della lingua italiana , inaugurato con la direzione di Salvatore Battaglia, alla voce dialetto noi possiamo leggere: «Parlata propria di un ambiente geografico e culturale ristretto (come la regione, la provincia, la città o anche il paese); contrapposta a un sistema linguistico affine per origine e sviluppo, ma che, per diverse ragioni (politiche, letterarie, geografiche, ecc.) si è imposto come lingua letteraria e ufficiale» (Torino, U.T.-E.T., 1966). Definizione, come si può notare, d'una grande sciatteria. Innanzi tutto perché contrappone (?!) un "sistema linguistico" alla parlata e al dialetto come se questi non fossero sistemi linguistici a loro volta. In secondo luogo perché rinchiude ogni dialetto entro barriere di realtà che linguistiche non sono, in quanto mere espressioni di una volontà tutta politica e amministrativa. La Campania , per esempio, è un'invenzione fatta a tavolino, non comprensiva di tutti i locutori della lingua partenopea e tuttavia assorbente anche linguaggi che di napoletano hanno ben poco. Inoltre non vi è città o paese che abbia una parlata propria ben conforme, perché variabili diverse intercorrono tra quartieri, generazioni e classi sociali. Per non parlare, infine, delle fatidiche province, istituzioni inutili e sprovviste di omogeneità linguistiche di cui, prese ad una ad una, solo uno sprovveduto può fare di tutt'erba un fascio. Si potrà in tal caso tentennare tra due differenti posizioni. Gli uni sostengono un assunto che permane d'ordine spaziale, come testimonia lo Zingarelli per il quale il dialetto è un «sistema particolare usato in zone geograficamente limitate» (M. Dogliotti e L. Rosiello, Bologna, Zanichelli, 1994). Per altri vi è sussunto ogni sistema linguistico di ambito geografico o culturale limitato, che non abbia raggiunto o non ha più un'autonomia e un prestigio in relazione a un altro «sistema divenuto dominante e riconosciuto come ufficiale, col quale tuttavia, e con altri sistemi circostanti, forma un gruppo di idiomi molto affini per avere origine da una stessa lingua madre» (A. Duro, Vocabolario della lingua italiana , Roma, Ist. Encicl. Italiana, 1987). La più recente dialettologia italiana ha però tentato di venir fuori dalle presunte unità compatte dei dialetti, in qualche modo contrapposte in sottovarietà al sistema dialettale dominante. Essa ha voluto riconoscere aporie di metodi di analisi consueti nelle scienze naturali, ma del tutto fuorvianti nello studio delle lingue, attestandosi in ricerche sulle tante varietà dei repertori linguistici e dei fenomeni da cui sono caratterizzati. Sennonché alla base delle innovative procedure resta intatto il presupposto ideologico di uno stato/nazione dentro il quale tutta la produzione linguistica dei cittadini locutori è obbligata a rispecchiarsi. Strumento arcaico, obsoleto, in via di rapida scomparsa. In tempi in cui si affermano diritti personali alla particolarità e alla universalità, ovvero alla propria tradizione culturale assieme all'apertura al mondo intero o, per dirla in altri termini, alla identità e alla differenza in cui ciascuno e tutti sono cittadini del villaggio planetario. Non penso che si possa immaginare una cultura universale e a maggior ragione una lingua che davvero sia parlata in ogni parte della terra. Tutto ciò che attualmente passa per globale è solo un'espansione a dismisura di una falsa verità che mercatizza il mondo. Penso, invece, che ci si difenda da una simile minaccia rafforzando ognuno la distanza critica perché l'egemone pensiero omologante non invada la coscienza e, al tempo stesso, la cultura d'altri popoli e paesi dia maggiore senso a quella nostra. Uno dei massimi linguisti del XX secolo, il rumeno Eugen Coseriu, definiva ogni dialetto come «un sistema d'isoglosse incluso in una lingue comune» (Los conceptos de "dialecto", "nivel" y "estilo de lengua" y el sentido propio de la dialectología , in "Lingüística española actual", 3, 1981, 1-32). Definizione nella quale occorre precisare che per "lingua comune" deve intendersi quella ufficiale di un paese che in sé includerebbe i "suoi" dialetti. In primo luogo c'è da dire che i linguisti non precisano i confini tra lingua comune e comunità linguistica, anche se la differenza è assai notevole sul piano delle identità locali e delle odierne egemonie di lingua e di cultura nel villaggio planetario, fino a espandere isoglosse dell'angloamericano a dismisura. In secondo luogo non s'intende il senso da fornire al termine "inclusione". In che modo, per esempio, il napoletano rimarrebbe incluso dentro l'italiano? Non risulta che vi sia un inserimento stabile o funzionale tra i due linguaggi, anche se da secoli è frequente il prestito reciproco e lo scambio lessicale. L'inclusione è tutt'al più fenomeno legato a relazioni tra una lingua regionale e i suoi dialetti, ma non corrisponde a ogni tipo di contatto e dunque non può essere un criterio universale di designazione. In tutta questa confusione vi è da ultimo lo sforzo di schiettezza che bisogna riconoscere a tre celebri linguisti come Corrado Grassi, Alberto A. Sobrero e Tullio Telmon, i quali hanno affermato che «[...] le effettive condizioni d'uso da parte dei parlanti sono il solo criterio universalmente valido per stabilire in quale relazione ogni singola varietà linguistica si pone rispetto alle altre dello stesso repertorio e, in particolare, per distinguere una lingua da un dialetto . Non regge alla prova dei fatti nessuno degli altri criteri che sono stati nel tempo e vengono tuttora invocati per spiegare o mettere in discussione tale distinzione [...]» ( Fondamenti di dialettologia italiana , Roma-Bari, Laterza, IV ed., 2001, p. 17. Corsivi degli autori). Dichiarazione, questa, che smentisce in pieno ogni pretesa nobiliare posta in capo alla nozione di dialetto richiamata da De Blasi come la risposta «all'esigenza di una chiarezza descrittiva scientifica», appartenente, addirittura, «a una tradizione scientifica consolidata e condivisa». Tradizione che a tal punto, come si conviene nel rispetto dell'onore dei lignaggi gentilizi, verrà fatta rispettare senz'alcun indugio. Tuttavia in tal caso la polemica riguarda il campo dei linguisti, di sicuro non quello ben più sobrio degli studiosi di filosofia e di storia delle idee, al quale e con gran merito appartiene Jean-Pierre Cavaillé. Non potremo che gioirne, perché il progresso delle scienze avviene, da che mondo è mondo, solo a seguito di sfide, controversie, dibattiti, contese combattute a colpi di argomentazioni, ipotesi, teorie. Per quanto mi riguarda, da semplice logofilo, amoroso cioè d'ogni linguaggio e di termini e nozioni nel dettaglio, voglio ricordare come, in tema di definizioni nominali, i maestri medievali delle scholae distinguessero con somma cura la quidditas , cioè l'essenza sostanziale della cosa nominata, dalla quodditas , ovvero il semplice accadere della cosa stessa. La quiddità esprime dunque il necessario della cosa designata, mentre la quoddità rinvia a un suo aspetto contingente. Ora la parola dialetto, così come viene «correntemente usata negli studi linguistici scientifici», per dirla alla De Blasi, o è un inutile doppione della lingua, in quanto alla propria essenza sostanziale, oppure nomina un'altra essenza. Universale è il fatto che la specie umana sia capace di linguaggio articolato. Universale, ancora, è il fatto che ogni popolo abbia una propria lingua che si diversifica in dialetti. E tuttavia, in ciò, nulla vi è di contingente. Nella produzione quotidiana e immateriale delle lingue contingenza è solo la diversificazione storica e sociale di ciascuna lingua, come precisò Giambattista Vico nel 1744. Contingenti sono pure le varietà fonomorfologiche diatopiche che fanno comparire in ogni lingua singolari forme dialettali che da essa si dipartono e in essa si riconoscono nel tempo. Così dal latino, per esempio, si diparte come lingua il napoletano sulla base originaria della lingua osca e per influenze successive d'altre lingue, producendosi, a sua volta, in forme affini e ben localizzate di autonomi dialetti. Se non la si mette in questi termini oggettivi si potrebbe dire che i linguisti fanno d'ogni lingua una babele. Quando il denominatore universale del dialetto fosse per davvero espresso solo dall'esiguo spazio noi dovremmo, allora, non chiamare lingue quelle che attualmente vanno estinguendosi nel mondo perché parlate da popoli culturalmente invasi. Se invece noi accettassimo il criterio d'una lingua resa tale solo in quanto propria di nazione con autonomia statale, allora, per addurre un solo esempio, ecco che il coniglio del dialetto cinese di Taiwan uscirebbe fuori come lingua dal cilindro dei linguisti. Lì dove questi hanno creduto di far ordine, ponendo termini precisi che in realtà non precisano un bel niente, siamo inoltre innanzi a un guazzabuglio generale. Se dialetto si dirà il napoletano, allora si dovrà forse chiamare subdialetto o in altro modo il caivanese o il procidano? E come mai, al contrario, si diranno tutte lingue quelle che si parlano nella nazione iberica? Il castigliano, infatti, è lingua ufficiale dello stato spagnolo e tutti i cittadini «hanno il dovere di conoscerlo e il diritto di usarlo» (art. 3 della Constitucion española), nondimeno, per la legge e nella pubblica opinione, esso convive accanto ad altre lingue, riconosciute come tali dalle comunità autonome, come il catalano, il gallego, il bable, l'aragonese e altre ancora. E ciò con buona pace e falsa coscienza dei linguisti della nostra bella Italia. Con tutto ciò credo che l'unica evidenza nel rapporto tra dialetti e lingue nella terminologia corrente sia quello di una subalternità ideologica dei primi nei confronti delle seconde e ciò in maniera del tutto impropria rispetto alle realtà linguistiche locali. Un tal rapporto di potere può e deve essere abolito, conservando l'ufficialità dell'italiano ed elevando allo statuto di linguaggi regionali i più importanti idiomi della Repubblica, anche in pieno ossequio della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie , così che le singole regioni decidano in sovrana autonomia i nomi da dare ai differenti insiemi linguistici del proprio territorio, ai particolari sottoinsiemi e alle loro rispettive funzioni sociali e culturali. Il napoletano ha tutte le carte in regola per dirsi lingua ad ogni effetto. Non è infatti una modalità o una varietà dell'italiano, sia di quello standard che di quello storico, né si sottopone all'ufficialità dell'italiano per motivi di maggior prestigio della lingua nazionale, ma soltanto in forza di un più vantaggioso comodato d'uso. Per altro la stragrande maggioranza dell'agire comunicativo in italiano dei milioni di persone che hanno nel napoletano la loro lingua originaria parla l'idioma nazionale in modo che di questo è tutt'al più variante. Infine sono del parere che tra dialetto e lingua non vi possa essere alcuna differenza sostanziale; le due nozioni hanno lo stesso senso, tranne il fatto che se ogni dialetto è lingua non è poi vero che ogni lingua sia un dialetto (almeno in questa fase storica); un dialetto è inoltre lingua, anche se si considera variante subalterna di una lingua prevalente (come accade a ogni dialetto della lingua napoletana e come accadde per il napoletano e il fiorentino quali originarie forme dialettali del latino); una lingua storica non ha nulla di eccellente o eccezionale, per il fatto di esser parte di un insieme storico di lingue affini e interdipendenti di cui sono membri anche i dialetti (così sono, infatti, l'italiano, il napoletano e altri idiomi d'Italia, come pure il francese e lo spagnolo, con le loro lingue regionali e i dialetti rispettivi); l'eccellenza stessa dell'italiano letterario e di quello scientifico è soltanto una variante (dialettale) della lingua standard nazionale. |
|||||||

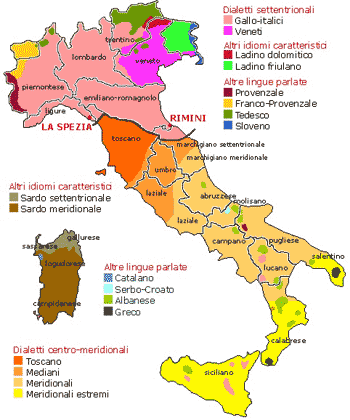



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F28%2F115864%2F127634996_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F12%2F76%2F115864%2F126788466_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F99%2F115864%2F50180922_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F65%2F115864%2F81511110_o.jpg)